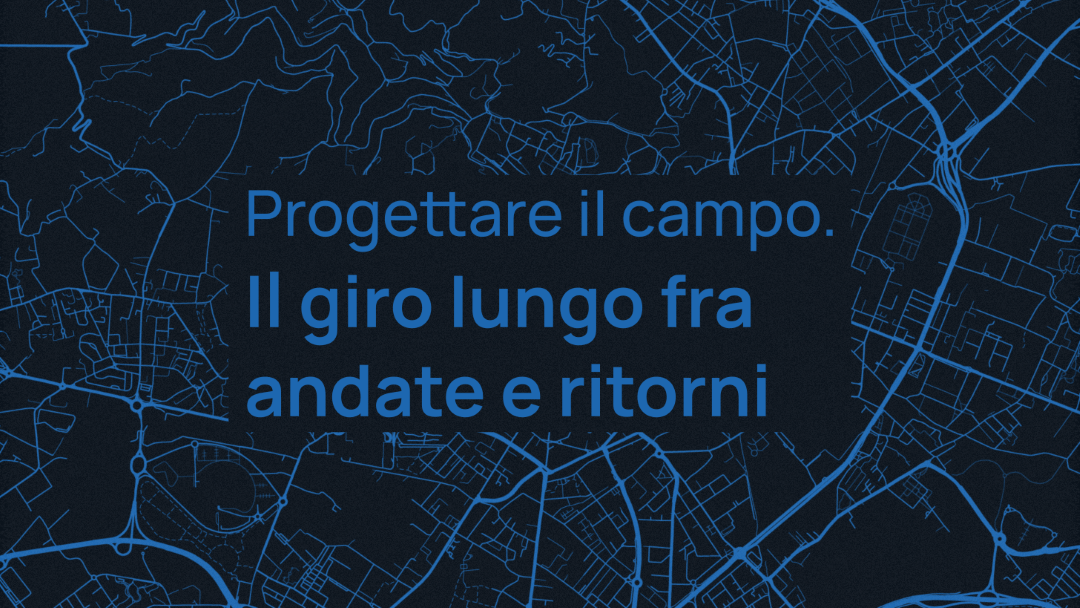
Tre di noi sono in ballo con dei campi di ricerca internazionali per la propria tesi di laurea. Alessandra e Emma stanno per partire, Leonardo è da poco tornato. Qui di seguito ci sono tre loro riflessioni su cosa significhi fare campo.
In partenza per Nassau (Bahamas), Alessandra
Il mio campo ufficialmente comincia tra molto poco, il 12 maggio, direzione: Bahamas. Nello specifico, andrò
nell’isola di New Providence, che ospita la capitale Nassau.
A parte l’evidente bellezza del contesto dove andrò, credo che una delle sensazioni che la mia prossima
partenza potrebbe suscitare sia: ma come ci sono finita a proporre un progetto di tesi alle Bahamas? Ecco, qui
non nego che ho avuto un immenso culo. Che in termini più formali si chiama serendipità. Credo di poter far
risalire questa storia a tre anni fa. Stavo cercando un argomento per la tesi di triennale, mi interessava già
l’antropologia economica, e mia mamma mi gira su whatsapp due interviste a un nostro cugino che è molto dentro
al mondo dei Bitcoin, questo è quello che sapevo allora. In realtà non è neanche un cugino, è il compagno
della cugina di mia mamma. Famiglia all’italiana direi. In uno di questi articoli leggo un’espressione che mi
accende la curiosità: la comunità dei bitcoiner. Se c’è una comunità, penso, allora un’antropologa può farci
una ricerca. Lo contatto e approva, faccio una videochiamata arraffazzonata con il mio relatore, lui a Lagos,
con alle spalle una notte insonne per aver perso le chiavi di casa, e io già ubriaca per la grigliata di
pasquetta: e approva. Così faccio la tesi con questo cugino, e dopo essermi laureata, in un lungo viaggio per
l’anno sabbatico, lo vado trovare. Dove? Alle Bahamas, dove abita con mia cugina e i loro figli. Quando sono
lì noto alcune cose molto interessanti, mi sembra di stare in uno di quei film ambientati nell’epoca
coloniale.
Prima di continuare, è necessario anteporre due premesse di contesto. Innanzitutto le Bahamas sono un paradiso
fiscale, espressione con cui si intende nella letteratura specialistica e nelle inchieste giornalistiche, una
giurisdizione che presenta un’inadeguata imposizione fiscale e disponibilità allo scambio di informazioni,
oltre che una sostanziale stabilità politica che permetta di mantenere l’indirizzo nel tempo. Naturalmente
dipende dai punti di vista: qualcun altro potrebbe definire i paradisi fiscali come stati che non derubano i
cittadini delle loro risorse e che li preservano da attacchi da parte di altri stati violenti.
Dipende dai punti di vista, appunto, e questo potrebbe essere quello di una delle popolazioni che abitano alle
Bahamas. Per quello che ho visto in quell’altra occasione in cui ho potuto visitare questo paese, la
popolazione che abita l’isola di New Providence si divide in neri e bianchi. I neri sono esclusivamente
bahamiani, afrodiscendenti, e si può generalizzare sufficientemente dicendo che si identificano come
popolazione caraibica anche se geograficamente non lo sarebbero e l’influenza statunitense in molti campi è
quasi ingombrante. Per quanto riguarda i bianchi, sono innanzitutto turisti, che a loro volta si dividono in
turisti brevissimi, quelli delle crociere, che arrivano alle 9 e se ne vanno alle 17 tutti i giorni, e quelli
di villeggiatura, che soggiornano per periodi più ampi ma comunque limitati. Poi ci sono i pensionati europei,
molto ricchi e che hanno acquistato una casa sull’isola per passarci la brutta stagione europea. La
popolazione che potrebbe definire i paradisi fiscali nel modo che ho descritto sopra si definisce “tax
refugee”, cioè quelle persone che letteralmente scappano dalle tasse e si rifugiano nei paesi con tassazione
nulla o quasi. I miei cugini rientrano in questa categoria. Ed infine gli expat, quei lavoratori
euro-nordamericani che soggiornano alle Bahamas per un minimo di tre e per un massimo di cinque anni, mandati
dalla banca o dalla multinazionale per cui lavorano, ma in questo gruppo sono inclusi anche i diplomatici.
Spesso passano la loro vita a cambiare paese, altre volte è solo un’esperienza unica e limitata nel tempo.
Questi abitano perlopiù in case fornite dall’azienda, e sono concentrati – a quanto ne so per ora – in una
gated community, Sandy Port, che è il luogo che studierò. Da questo punto di vista vorrei analizzare le
conseguenze sociali e spaziali nelle Bahamas dell’essere un paradiso fiscale.
Ecco quindi come ci sono arrivata, e come ho dato senso a questo caso, o serendipità, o culo, che dir si voglia.
Ma, quindi, questo campo è già iniziato? Quando inizia davvero il campo? mi chiedeva Emma nella preparazione
di quest’incontro. Ecco, la mia prima risposta sarebbe stata: molto prima di partire effettivamente. Eppure,
si può a questo punto definire un limite? Rischia di diventare un esercizio fazioso, e ad impegnarsi potremmo
arrivare ad affermare che il mio campo è iniziato il giorno della mia nascita. Ho iniziato dunque a
immaginarmi il campo come diverse mappe. Ci sono diversi tipi di carta geografica, infatti: quella che ne
rileva le pendenze, quella che rappresenta solo le strade, o solo i confini politici, o i rilievi fisici. Il
campo dunque è il luogo fisico in cui mi muoverò, ma anche le relazioni che intesserò, i percorsi
bibliografici che sto seguendo, e tutte le bozze e i documenti salvati con nomi improbabili sul mio pc. Ma a
livello temporale si può dare un inizio del campo? Credo non si possa negare che il campo cominci prima
dell’effettivo viaggio in aereo, eppure forse possiamo dire che il momento in cui inizia, a livello temporale,
include le prime azioni che compiamo per costruirlo, includendo solo le azioni che abbiano delle conseguenze
dirette su questa costruzione. Quindi magari i miei primi contatti con l’università bahamiana potrebbero
essere i momenti in cui è iniziato il campo, che è continuato quando ho iniziato a cercare per le biblioteche
di tutta Europa i libri sulla storia delle Bahamas.
Analizzare i momenti di preparazione, anche quelli più banali, mi sembra molto interessante perché permette di
vedere che aspettative abbiamo. Per quanto mi riguarda, ad esempio, nella lista delle cose da mettere in
valigia ci sono dei tacchi, degli abiti carini e dei reggiseni. Ho prenotato anche l’estetista prima di
partire. Questo perché mi aspetto di introdurmi in gruppi che hanno un certo standard estetico, e non vorrei
che non conformandomi ad esso si approccino a me con dei pregiudizi.
Ma a questo punto c’è da chiedersi: quando finisce il campo? Quando finirò di scrivere la tesi? O quando tornerò, perché dopo sono solo speculazioni su di esso? Mi chiedo infine se non sia in realtà tedioso chiedersi queste domande, o meglio: se l’esperienza etnografica non sia alla fine una parte di vita dell’antropologa, inserita in un lungo percorso biografico, e dunque non davvero scindibile da, appunto, la mia vita al di fuori del territorio geografico delle Bahamas.
In partenza per Hong Kong, Emma
Mancano poco meno di due mesi alla partenza. Ho preso il biglietto aereo di andata: Milano/Doha, Doha/Bangkok, Bangkok/Hong Kong — 23 ore di viaggio. Sarò a 9.340 chilometri e 6 ore di fuso orario da Milano. Non ho ancora preso il biglietto di ritorno, non ho ancora trovato una casa, non ho ancora stipulato un’assicurazione sanitaria, non ho ancora controllato se la mia carta funzioni in Cina né se siano necessarie vaccinazioni. Ma ho comprato una lonely planet su Hong Kong, visto “Chungking Express” e “Fallen Angels” di Wong Kar-wai, imparato a cucinare il mapo tofu, letto “A Modern History of Hong Kong” di Steve Lang, studiato fino alla quinta unità il manuale di cantonese e capito le regole del Mahjong. La verità è che non ho ancora fatto tutte le cose oggettivamente utili e importanti per colpa del profondo senso di scaramanzia che mi accompagna. Ho passato gli ultimi mesi a collezionare tutti i documenti necessari per la domanda di visto: un lungo elenco di certificazioni, lettere e timbri. Ho applicato al bando, preso la borsa di studio e firmato tutti gli accordi di mobilità, ora manca solo lo scoglio “Ufficio Immigrazione della Repubblica Popolare Cinese”. Entro quattro settimane scoprirò se posso effettivamente entrare a Hong Kong, quindi ormai la situazione è fuori dalle mie mani e devo farmene una ragione. Nonostante senta di aver fatto il possibile, nella disperazione mi sono convintə che giocare a Mahjong online possa in qualche modo giovare al mio caso e sono dunque al livello 31 di Mahjong Club Solitaire. Qualche giorno fa, mentre ragionavamo insieme sull’incontro, Ale diceva: “Ma quando inizia secondo voi il campo? Quando comincio a prendere le note di campo?”. Riflettendoci e discutendone non ho trovato una risposta che possa andare bene per tutti ma ho deciso, sempre causa scaramanzia, che il mio campo comincerà quando, e se, riceverò il visto. Sarà il momento in cui potrò finalmente tirare un sospiro di sollievo e pensare a come accedere per davvero al campo e non solo a come attraversarne il confine nazionale. Per quanto ritengo sia utile scherzare ed esorcizzare la mia ansia, è anche vero che continuare a parlare del campo al condizionale mi permette di allontanarlo, di dilatare la sua realtà nei grovigli burocratici e non soffermarmi sul fatto che non ho assolutamente idea di come possa andare. So come si fa un’intervista, conosco la storia dell’amministrazione residenziale di Hong Kong, ho degli strumenti e delle conoscenze ma sarà la prima volta in cui li metterò effettivamente “in campo”, e in un campo che davvero mi interessa. Molto spesso ho sentito antropologə parlare del campo come di un posto in cui sono capitatə un po’ per caso, come se non l’avessero propriamente scelto ma fosse quasi stato il campo stesso a sceglierlə. Io non credo proprio che Hong Kong mi abbia scelto, anzi penso abbia fatto tutto il possibile per rendersi complessa e respingente. Eppure, non so per quale motivo, la mia malsana ostinazione non è mai diminuita né vacillata, e questa cosa in realtà mi spaventa parecchio: mi sembra molto più semplice pensare di essere capitatə sul campo per caso e aver poi sbagliato, piuttosto che di aver scelto con tutta questa testardaggine di andare a Hong Kong per poi sbagliare. Sono comunque consapevole che il concetto di sbagliare sia molto soggettivo, che sbagliando si impara e che io vada principalmente per imparare, però, più il tempo passa più continuo a chiedermi “ma perché Emma santo cielo ti sei infilatə in questa cosa?”. Non lo so, so che ha senso perché persone più esperte di me hanno approvato il progetto ma non so perché io lo stia facendo, sarà un po’ di sindrome dell’impostore, chi lo sa. Sta di fatto che sono molto felice e non vedo l’ora di partire ma, ecco, rispondere a questa domanda al momento non lo so proprio fare. Spero di trovare una risposta, o perlomeno un suggerimento, una volta che avrò percorso questi 9.340 chilometri, vi aggiornerò.
Di ritorno da Mauritius, Leonardo
La mia ricerca si è svolta a Mauritius, dove vive oggi la maggior parte della comunità chagossiana, deportata
tra gli anni ’60 e ’70 dalle isole Chagos, un arcipelago dell’Oceano Indiano trasformato in una base militare
statunitense. Ho seguito da vicino le attività del Chagos Refugees Group (CRG), il principale gruppo di
attivismo chagossiano. Ho partecipato a riunioni, commemorazioni pubbliche e momenti più informali, cercando
di capire, attraverso testimonianze, osservazioni e tante conversazioni, come si costruiscono memoria,
identità e rivendicazione politica in una situazione di esilio forzato.
Potrei dire che la mia ricerca è cominciata davvero il giorno in cui, al mio primo incontro con Olivier
Bancoult, presidente del CRG, mi è stato chiesto: “Che cosa vuoi da noi?”. Quella domanda, semplice e diretta,
ha segnato l’inizio di una relazione, ma anche di una riflessione continua sul mio ruolo e sul senso stesso
del “fare campo”.