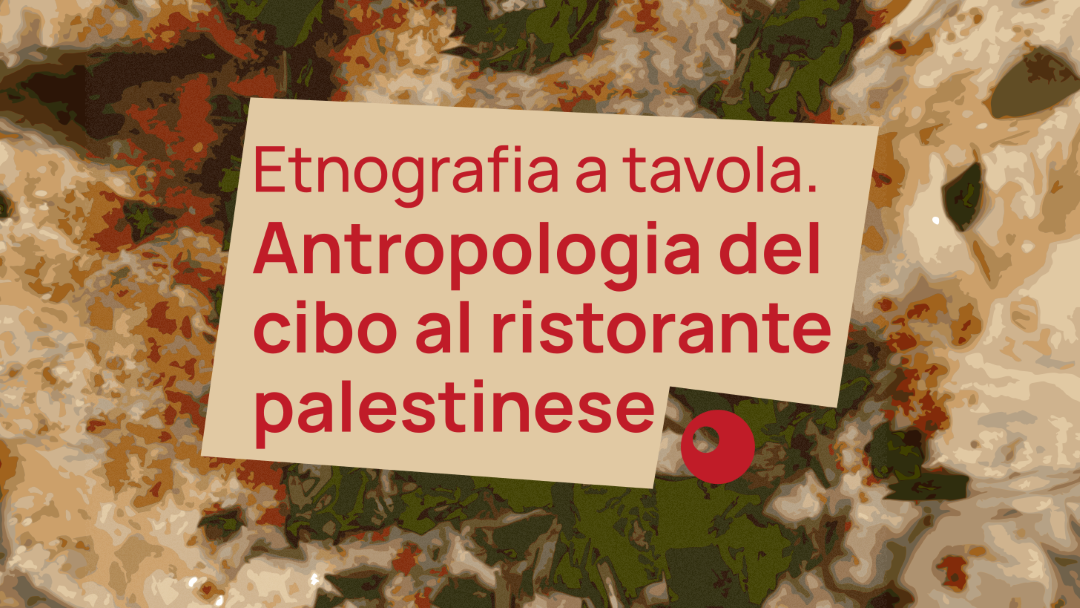
2025-04-11. 13:19. Street Food Betlemme.
Io, Diana, Emma e Maddalena arriviamo da Bicocca dopo mezz’ora di metropolitana, ad aspettarci ci sono già Alessandra, Leonardo e Sara. Dopo i convenevoli di rito, entriamo una prima volta nel locale per prendere i menù e iniziare a decidere sul da mangiarsi. Il posto è piccolo, il bancone che percorre l’intera lunghezza dell’ambiente lo fa sembrare più un corridoio che una stanza. La metà di sinistra è occupata dalla cucina a vista, sul bancone sono impilati i menù e gli imballaggi usati per l’asporto, a destra c’è una porta aperta di cui non mi preoccupo molto. Pareti e bancone sono ricoperti da maioliche tutte uguali; motivi vegetali con colori accesi e sfondo bianco si ritrovano anche sulle stoviglie. Appese un po’ ovunque, immagini – fotografie e illustrazioni – della Palestina e della sua bandiera. I menù li leggiamo di fuori, sul marciapiede che si allunga fra l’ingresso e il mini-dehors (grande meno di due posteggi lungo la strada) con otto tavolini tutti occupati; altri corridoi, questa volta senza muri. Decidiamo cosa ordinare e rientriamo; già in quattro ci si pesta i piedi a vicenda. Ordino io per tutti: cinque porzioni di falafel, una di shawerma, due di dawali (involtini di foglie di vite), una di hummus, una di ful (crema di fave) e una di moutabal (crema di melanzane affumicata); tutto da portare via, grazie. Uscendo, scopro che la porta aperta nella parete conduce ad un locale adiacente, con un bancone di dolci e altri tavolini. Dalla strada si presentano come due entità distinte: Betlemme Street Food a sinistra, pasticceria mediorientale Al Nabulsi a destra. Mentre aspettiamo di venire serviti restiamo fuori a chiacchierare; Diana parla coi proprietari, è stata in Palestina, parla un po’ l’arabo.
Ritiriamo il cibo e ci accampiamo all’ombra di uno degli alberi dei vicini Giardini di Porta Venezia. Mangiamo con calma e intanto continuiamo a chiacchierare. Il sole ci trova in fretta e mi ricordo di aver dimenticato di mettere la crema solare in faccia, scusa mamma. Diana ci racconta che in Palestina ci è stata due volte, con un'associazione di Milano che organizza viaggi di conoscenza durante i quali si incontrano attivisti, volontarie e volontari di associazioni culturali nelle principali città della Cisgiordania e nella Valle del Giordano. Il nostro pranzo continua con alcuni aneddoti di questi viaggi, legati al cibo e non, e altre divagazioni.
Finito il pasto, entriamo di più nel merito dell’ordine del giorno: Diana tira fuori dallo zaino un paio di libri e inizia a parlare del cibo palestinese. Anch’io e Maddalena abbiamo letto qualcosa a riguardo, e non posso togliermi dalla testa l’impressione che se si parla di cucina palestinese, nel 90% dei casi è perché si sta decostruendo la cultura del cibo israeliana. Alla fine, un antropologo studia il cibo soprattutto per la sua dimensione simbolica, credo, e se c’è una cosa che trova nel cibo un grande collegamento fra piano reale e simbolico, è l’identità. Una delle prime cose in cui ci si imbatte quando si entra nell’argomento, è la mimesi che la cucina israeliana ha compiuto su quella palestinese; come anche negli altri aspetti della vita, il progetto sionista ha puntato a naturalizzare la sostituzione che sta compiendo in Palestina. I piatti locali vengono rivendicati come essenza dell’identità del “Nuovo Ebreo” e falafel, hummus, olive vengono ascritti ai popoli biblici, di cui i palestinesi non sarebbero che una pallida emanazione contemporanea. Una presenza da imitare, almeno all’inizio, perché proprio in virtù di questo ideale collegamento biblico i palestinesi rappresentano un’importante fonte identitaria. L’invenzione di una cultura culinaria israeliana rispondeva anche alla necessità di imporre un’identità unica alla grande varietà che si ritrovava fra gli ebrei provenienti da diverse parti del mondo. Progetti simili li troviamo anche altrove, come nella cucina indiana, unificata dalla presenza coloniale. E li ritroviamo nella stessa cucina palestinese che, presentandosi unita e nazionale, nasconde le differenze regionali nella diffusione e preparazione delle ricette. Cibo e nazionalismo sono una coppia ben salda, che trova il suo successo nell’apparente estraneità del cibo ai processi politici. Mangiamo per vivere, per soddisfare la fame, non sembra esserci molto di più dietro. Nella realtà, però, scegliamo attentamente cosa mangiare e cosa no, e tutto viene giustificato con scelte identitarie individuali o collettive. Se siamo ciò che mangiamo, il cibo della nostra terra definisce la nostra cittadinanza – da italiani ne sappiamo qualcosa. Si spiegano più facilmente le “Hummus Wars,” ovvero la sfida a creare il piatto di hummus più grande del mondo (una trovata pubblicitaria statunitense) evolutasi in uno scontro fra Israele e Libano. La cucina palestinese rientra nella più grande, e dai contorni ancora più sfumati, cucina mediorientale. La rivendicazione di specifiche ricette o pratiche si palesa subito come una mossa politica. Ritorniamo allora al mio pensiero iniziale: se la cucina palestinese esiste, è anche perché deve porsi come linea di resistenza alla sostituzione che la cosiddetta cucina israeliana sta avanzando. Una resistenza sottile, apparentemente innocua come il cibo, ma che si sviluppa dappertutto. Dalla diffusione della birra palestinese Taybeh, con lo slogan “assapora la Rivoluzione,” alla promozione di cibo baladi (“locale,” “fatto a mano”) nei mercati, coltivato negli orti palestinesi e preferito alle produzioni industriali israeliane.
Una cosa che emerge dai racconti sul cibo in Palestina è l’abbondanza che deriva dalla grande ospitalità. Abbondanza che si traduce in eccesso, un eccesso consapevole; se il cibo finisce, vuol dire che non si è stati abbastanza ospitali. L’abbondanza si ritrova anche nei dolci e nelle bevande, carichi di miele e/o zucchero. Lo dice chi ci è stato, e lo dico anch’io dopo che abbiamo concluso il pasto con dei dolci assortiti che Diana ci ha comprato nell’altro locale mentre aspettavamo l’ordine.
Bibliografia per approfondire
- Abuhamdiya, Fidaa e Chiarantini, Silvia. 2024. «Pop Palestine. Viaggio nella cucina popolare palestinese»
- Avieli, Nir. 2016. «The Hummus Wars Revisited: Israeli-Arab Food Politics and Gastromediation». Gastronomica 16 (3): 19–30.
- Baron, Ilan Zvi e Galia Press-Barnathan. 2021. «Foodways and Foodwashing: Israeli Cookbooks and the Politics of Culinary Zionism» International Political Sociology, pp. 338-358.
- Jerusalem Quarterly 98 e 99. Special Issue: Food and Foodways part 1 & 2. 2024.
- Kassis Reem (trad. di Silvia Rota Sperti). 2023. «La cucina palestinese e l’appropriazione culinaria israeliana» in The passenger: Palestina, 178-183.
- Meneley, Anne. 2014. «Resistance Is Fertile!» Gastronomica 14 (4): 69–78.
- Ranta, Ronald. 2015. «Food and Nationalism: From Foie Gras to Hummus». World Policy Journal 32 (3): 33–40.
- Ranta, Ronald, e Yonatan Mendel. 2014. «Consuming Palestine: Palestine and Palestinians in Israeli food culture». Ethnicities 14 (3): 412–35.
- Van Aken, Mauro. 2015. «Immaginari di natura. Mangiare e coltivare cibo baladìì (locale) nel Territori Palestinesi». Im@go. Rivista di Studi Sociali sull’Immaginario, fasc. 5, 39–65.