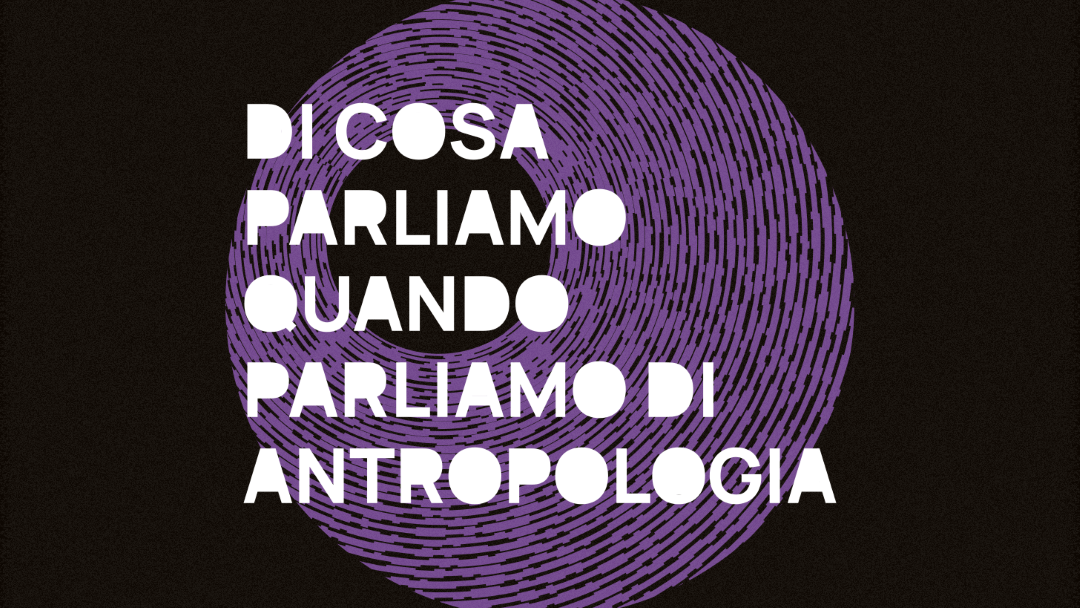
Dopo la guerra, andai all’Università di Chicago, dove ebbi il piacere di studiare antropologia, una scienza che era soprattutto poesia, e che non comportava lo studio della matematica.(Kurt Vonnegut, intervistato da The Paris Review nel 1977)
"I confini dell’antropologia sono sempre stati problematici – ancora di più, si crede, di quelli di altre scienze o discorsi sociali." Inizia così un articolo di Stocking (1995)1 sui "confini di una disciplina sconfinata" e da qui emerge la domanda di questo incontro: che cosa dice un antropologo quando deve spiegare il proprio lavoro? Sembra che chi non lo sa non possa impararlo, e chi lo sa non riesca a spiegarlo. Io stesso fatico a definire il perché ho scelto di intraprendere questi studi e sono solito rispondere, fra il serio e il faceto, che la mia motivazione principale è stata quella di fare una cosa che nessuno sapesse cosa fosse, con buona pace delle domande di amici e parenti.
Negli ultimi mesi, leggendo testi etnografici, mi sono imbattuto più volte in frasi che rivelano qualcosa della disciplina e delle persone al suo interno, e ho iniziato a collezionarle. Lungi dall’essere una raccolta sistematica, o anche solo rappresentativa, credo che questi passaggi possano offrire degli spunti su cosa ci sia all’interno di questo sapere evasivo. Se l’intera disciplina è caratterizzata da definizioni sfumate, di certo anche le sue sezioni interne non possono creare domini netti e senza sovrapposizioni; ho comunque raggruppato le citazioni in tre macrosezioni: cosa è l’antropologia, chi è l’antropologo, e cosa fa un antropologo.
Cosa è l’antropologia?
Stando a definizioni puramente teoriche, l’antropologia è la scienza dell’umano e si potrebbe intendere
che tratti una vasta gamma di argomenti. […] Ma le scienze non crescono stando alle definizioni.
(Boas, 1899)1
Già nei primi anni della disciplina ci si è imbattuti nel problema della sua definizione. Non tanto perché questa non esista – dato che è esplicitata direttamente nel nome – quanto perché non offre nessuno spunto particolare sulla peculiarità di tale sapere. Nello stesso articolo, Boas spiega il valore dell’antropologia partendo dalle sue conseguenze:
Una conoscenza generale dell’antropologia sembra avere un valore educativo, soprattutto perché allarga
le visioni storiche dello studente, in quanto estende il suo sguardo su culture e civiltà che sono
cresciute fuori dall’influenza della nostra. (Boas, 1899)
Si trova qui un elemento condiviso da molti: il carattere dell’antropologia come modalità di sguardo rivolto
agli altri, prima che a noi. È un sapere che allarga ed espande delle conoscenze che presentano già delle basi
in noi. Non ha un oggetto specifico di ricerca ma un modo particolare di analizzare tutti gli oggetti, e i
soggetti, che incontriamo.
Stocking individua fra gli ostacoli maggiori alla definizione dell’antropologia la sua frammentazione interna.
Frammentazione che non deriva da una progressiva specializzazione del sapere, con un conseguente
restringimento del campo di ricerca, ma dalle multiple influenze che hanno plasmato la disciplina nel tempo.
Dice che, "di contro [alle altre discipline], lo sviluppo storico dell’antropologia si è configurato tramite
processi di fusione invece che di fissione." È la scienza dell’umano oggi tanto quanto lo era
centocinquant’anni fa. Le differenze storiche, e geografiche, emergono dal contesto specifico in cui
l’antropologo opera. L’etnologia francese, l’antropologia sociale britannica, la demologia italiana e
l’antropologia culturale statunitense sono versioni particolari di un sentire comune; le loro differenze, non
solo nominali, non alterano il loro status di sapere antropologico.
L’"Antropologia" non è una materia quanto un legame fra le materie. È in parte storia, in parte
letteratura; in parte scienza naturale, in parte scienza sociale; ambisce a studiare gli esseri umani
dall’interno e dall’esterno; rappresenta sia un modo di guardare all’umano che una visione dell’umano – la
più scientifica delle discipline umanistiche, la più umanistica delle scienze.
(Wolf, 1964)1
Nel 1960, Lévi-Strauss tenne la lezione inaugurale per la cattedra di antropologia al Collège de France. In questa, spiega che le altre scienze "non saprebbero come arrivare alla generalità senza la cooperazione dell’antropologia"1. Viene evidenziata qui, e nella frase di Wolf, la dimensione di supporto della disciplina: la difficoltà descrittiva deriva dalla sua natura interdisciplinare. Nello stesso discorso, Lévi-Strauss accenna al tardivo riconoscimento accademico dell’antropologia e, per quanto questo abbia causato dei problemi all’antropologia – tra cui, a mio avviso, un discreto complesso di inferiorità nei confronti delle altre scienze – credo che sia un altro punto a favore dell’unicità della disciplina. Già in tempi non sospetti, l’antropologia ha mostrato i vantaggi di un approccio dedito alla fusione piuttosto che alla fissione.
"L’obiettivo dell’antropologia è l’allargamento dell’universo di discorso sull’umano" ha detto Geertz (1973)1 ma una definizione del genere non ci aiuta molto. Non esprime nulla che non possa andar bene anche per molte altre discipline. Preferisco citare Fabietti, quando scrive:
L'antropologia non è – come purtroppo qualcuno ingenuamente o maliziosamente crede – una chiacchierata
sulla "diversità" e la "relatività" dei costumi. L'antropologia costituisce uno sforzo – che non sempre
riesce, beninteso – di stabilire un "ponte concettuale" tra culture, memorie, storie e identità diverse.
Se questo ponte servirà poi a stabilire o meno un dialogo, non dipenderà certo (soltanto) dagli
antropologi. (Fabietti, 2016)1
Centrale qui è l’idea di relazione, di dialogo, di connessione. La scienza dell’umano è quella che mostra come l’elemento più importante per noi sia la realtà di costante interconnessione con ciò che ci circonda: gli altri esseri, umani e non umani, i sistemi simbolici a cui ci affidiamo, la storia che ci ha segnato. Riconoscendo il primato della relazione, l’antropologia stessa non può chiudersi dentro i confini di una disciplina accademica e offrirci una definizione lapidaria riguardo la sua natura e i suoi obiettivi.
Il nostro obiettivo finale è quello di arricchire e approfondire la nostra visione del mondo, di
comprendere la nostra natura e di affinarla, intellettualmente e artisticamente. Nel capire la prospettiva
essenziale degli altri con il rispetto e la vera comprensione dovuti anche al selvaggio, noi non possiamo
che contribuire ad ampliare la nostra. Non possiamo assolutamente raggiungere la suprema sapienza
socratica della conoscenza di noi stessi se non lasciamo mai i ristretti confini dei costumi, delle
credenze e dei pregiudizi entro cui ogni uomo nasce. Niente può giovarci in tale questione di estrema
importanza più dell’atteggiamento mentale che ci consente di trattare le credenze e i valori di un altro
uomo dal suo punto di vista. Né mai l’umanità civile ha avuto bisogno di questa tolleranza più di adesso,
quando i pregiudizi, la cattiva volontà e lo spirito di vendetta dividono le nazioni europee, quando tutti
gli ideali, nutriti e proclamati come le più alte realizzazioni della civiltà, della scienza e della
religione sono stati gettati al vento. La scienza dell'uomo, nella sua versione più pura e più alta, ci
dovrebbe condurre a questa conoscenza, a questa tolleranza e a questa generosità, basate sulla
comprensione dei punti di vista degli altri uomini. (Malinowski, 1922)1
Con queste parole, con le quali Malinowski concluse la sua monografia, possiamo aggiungere un tassello al discorso: l’antropologo guarda gli altri per imparare qualcosa prima di se stesso, poi della propria società. Il sapere etnografico investe in primo luogo il ricercatore, allarga ed estende il suo sguardo prima di agire su quello degli altri. L’antropologia non avrà dei confini ma aiuta a individuare quelli delle persone: uscendo dalla propria rete sociale rivela come questa abbia dei limiti, lungo i quali si interfacciano diverse altre reti su cui non si ha il controllo.
Chi è l’antropologo?
Così come l’antropologia è una scienza che sta nel mezzo, l’antropologo è una persona a metà. Non nel senso che non ha raggiunto un livello di completezza che altri hanno; è a metà perché incorpora la dimensione ambigua in cui la disciplina si muove. Non sta da una parte o dall’altra, in dimensioni finite e identificabili; si ritrova nel mezzo delle relazioni, sul ponte fra culture.
Pur ritenendosi umano, l’etnologo cerca di conoscere e di giudicare l’uomo da un punto di vista
sufficientemente elevato e distaccato, per astrarlo dalle contingenze particolari a una data società o a una
data civiltà. Le condizioni di vita e di lavoro dell’etnografo lo staccano fisicamente dal suo gruppo per
lunghi periodi; la brutalità dei cambiamenti ai quali si espone produce in lui una specie di disancoramento
cronico: mai più si sentirà a casa sua in nessun posto, rimarrà psicologicamente mutilato. Come la
matematica o la musica, l’etnologia è una delle rare vocazioni autentiche. Si può scoprirla in noi anche
senza che ci sia mai stata inculcata. (Lévi-Strauss, 1955)1
L’antropologo, uscendo dai propri limiti, entra in un limbo che gli richiede di cambiare. Perde alcuni legami, ne costruisce altri, ma rimane invischiato in queste tensioni. Non ritorna mai come è partito; come la disciplina che promuove, è costantemente definito dal contesto in cui si muove e dalle fusioni che vive. Desiderando di avvicinarsi ai nativi di un luogo, diventa straniero ovunque, persino a casa propria. È questo straniamento che rende l’antropologo un essere a metà – un essere un po’ storto, se posso usare questa parola. L’interstizio in cui l’antropologo si ritrova, però, non è semplicemente un risultato del fare etnografia; come Lévi-Strauss afferma, è una condizione che possiamo vivere a prescindere dallo studio.
Non avevo mai preso l’abitudine alla pratica religiosa, anche se, allora come oggi, apprezzavo le
tradizioni religiose e le riconoscevo come significative. In seguito, nell'antropologia, trovai la
disciplina perfetta per chi condivide la mia condizione esistenziale; essa richiede il rispetto e incoraggia
la comprensione, ma non esige una piena adesione. (Abu-Lughod, 2021)1
Abu-Lughod, nella postfazione alla sua etnografia, riafferma la dimensione non universale dell’antropologia e la capacità di questa di rispondere ad un bisogno individuale prima ancora che ad un obiettivo collettivo. Quando ci si ritrova a metà, le soluzioni non possono arrivare da un punto solo, e comunque, quelle che si trovano, non saranno mai complete. L’antropologia offre un sostegno alle altre discipline e ai suoi studenti nello stesso modo: rivela i confini e obbliga ad accettarli, insegna a usarli ma non a costruirli né tantomeno a distruggerli. La condizione esistenziale di chi si ritrova sui confini è quella di chi non appartiene né a una parte né all’altra. A questo proposito, esco dalle parole degli antropologi per entrare in quelle di un romanzo: The Anthropologists di Aysegül Savas (2024). Parla di una coppia di giovani espatriati conosciutisi in università mentre studiavano antropologia; finiti gli studi, sono alla ricerca di un appartamento per vivere insieme in un paese straniero a entrambi, di cui quasi non conoscono nemmeno la lingua. Il libro è narrato dal punto di vista di lei, che spesso si immagina cosa penserebbe un’antropologa se li stesse osservando come nativi di quella cultura nata nel mezzo delle tre culture di cui non sono davvero nativi (quella di lui, quella di lei, e quella del paese in cui si sono trasferiti). La protagonista sente la necessità di affidarsi all’antropologia “perché spesso mi sembrava che la nostra vita non fosse reale, e interpellavo l’antropologa per farla sembrare altrimenti.”
Cosa fa l’antropologo?
L’antropologia culturale è importante […] perché riscopre costantemente il normale.
(Sapir, 1932)1
La dissoluzione di religione, politica, economia, parentela, e di tutte le altre forme con cui
l’esperienza umana si presenta alla mente socializzata, deve essere lo scopo dell’antropologia in
generale. (Gell, 1992)1
Esplicita i modi dati per scontato e spesso taciti con cui le persone danno senso alle loro vite.
L’etnografo abita a metà fra i mondi, al contempo nativo e straniero. (Hine, 2000)1
Quindi cos’è che fa l’antropologo? Dipende a chi lo chiedi. Credo che un elemento importante del lavoro etnografico sia quello di farti cambiare il punto di vista da cui osservi. Che la si chiami “riscoprire il normale,” o “esplicitare le cose date per scontate,” o “dissolvere le forme dell’esperienza,” una delle azioni principali dell’antropologo è quella di cambiare prospettiva. Sì, studia le strutture di parentela, gli scambi di doni, i rituali, le tradizioni e i significati di sacro e profano. Studia tante cose particolari ma, in generale, applica un metodo di studio che trasforma, traduce e altera qualcosa che si sa già.
“Cosa fa l’etnografo?” – scrive. O, più precisamente, “inscrive.” (Geertz, 1973)
Ciò che fanno gli antropologi è scrivere, ha sostenuto giustamente Clifford Geertz. Ma per il momento mi
dedico all’attività che, come ha altrettanto giustamente detto Clarissa de Waal (2005)1, costituisce l’altra
metà del lavoro degli antropologi: aspettare. (Vietti, 2012)2
Ciò che gli antropologi dovrebbero fare è porre domande che permettano di formularne di nuove,
possibilmente migliori. (Finnström, 2016)1
Come lo fa? Principalmente facendosi tante domande e provando a scrivere delle risposte. Non si producono mai, però, dei risultati finali e autonomi; le teorie generali non hanno vita lunga, soprattutto in antropologia. Resta presente la dimensione di interconnessione, per cui altri antropologi continueranno a porsi domande sulle risposte degli altri, insieme, si spera, a tutte le altre professionalità.
Infine, queste sono alcune delle risposte che diamo a chi ci chiede cosa è l’antropologia – e a chi è ancora
più incosciente da chiedere che lavoro faremo: è un discorso sull’umano; è lo studio delle culture; è fare i
pettegoli, citando Aristotele; è prepararsi a fare il mediatore culturale; è uno studio dal basso delle
società; è complicato.
Sicuramente la storia della disciplina non ci aiuta in questo compito. Le gerarchie dei saperi hanno a lungo
oscurato questa disciplina; l’ignoranza generale nei confronti dell’antropologia non è certamente dovuta solo
alla difficoltà di incasellarla. Nelle librerie, la sezione “antropologia” – quando c’è – è ridotta all’osso e
accostata a quelle di “mitologia” o “filosofia orientale”. Negli altri prodotti di intrattenimento la figura
dell’antropologo è spesso assente e, quando c’è, è mitizzata ed esotizzata.
Ovviamente il panorama non è tutto positivo. L’accento che ho posto più volte sulla relazione e
sull’interdisciplinarietà non rappresenta la totalità della ricerca antropologica. Si tratta per lo più di una
mia interpretazione, di cosa parlo quando parlo di antropologia.
L’archeologia è l’antropologia del passato, la fantascienza l’antropologia del futuro (Joan Vinge)